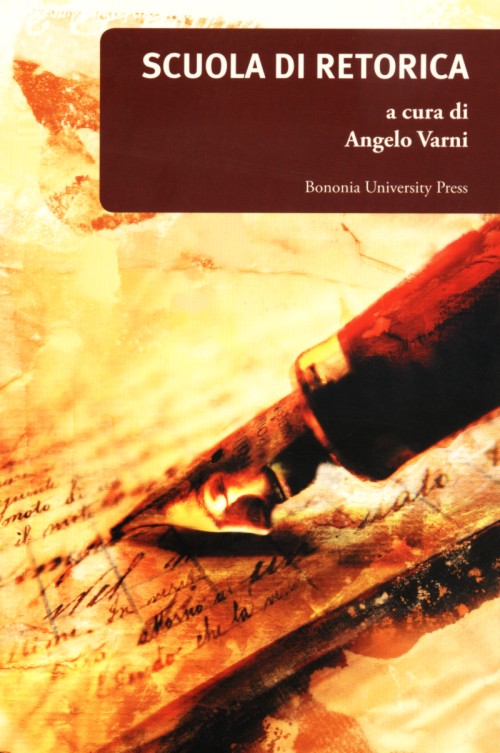Paolo Albani
ALCUNI BIZZARRI EPIGRAMMISTI
DEL NOVECENTO ITALIANO
CON UNA DIVAGAZIONE SULLA BREVITÀ
(estratto)
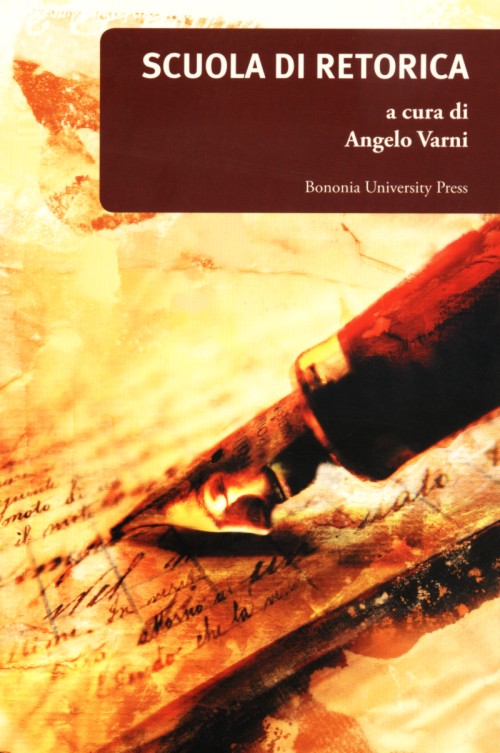
Appunti sull'epigramma
stesi in preparazione del dialogo con Gino Ruozzi,
avvenuto il 30 aprile 2004, nell'ambito degli incontri della Scuola
di retorica 2. Alcune tradizionali
figure della retorica nei
linguaggi
dell'oggi tenutisi nell'Aula Absidale di S.
Lucia a Bologna, incontri cui hanno partecipato
Andrea Battistini e Lucio Dalla (metafora),
Gian Luca Farinelli e Gianni Venturi (allusione),
Giorgio Sandri e Luigi Stortoni (argomentazione),
Gian Mario Anselmi e Alessandro Bergonzoni (ironia).
Nel testo non figura Gino Patroni (1920-1992), l'autore di Ed è subito pera, il più grande epigrammista italiano, proprio in virtù del fatto che in questo scritto mi occupo di epigrammisti monori.
Una sintesi di questo scritto è stata pubblicata su Scuola
di
retorica, a cura di Angelo Varni, Bonomia University Press,
Bologna,
2006, con il titolo «L'epigramma 2» (pp. 307-314).
Per scaricare la versione integrale di questo intervento in pdf cliccate qui.
Sommario
Premessa
Gli epigrammisti de il Caffè
Alfredo Bonelli e la «vita da libri»
Learco Pignagnoli
Flavio Oreglio
Gli «epigrammi ruspanti»
Sandro Dorna
Il «limericco» italiano e dintorni
L'aforisma involontario
Una postilla personale
Una macchina per fabbricare aforismi
Una divagazione sulla brevità
Premessa
In questo sintetico excursus
(come, del resto,
richiede
il tema trattato) mi soffermerò sui testi di alcuni epigrammisti
minori del Novecento italiano, quasi tutti non presenti nelle antologie
e nei repertori degli studi accademici, epigrammisti che potremmo anche
definire anomali, bizzarri, eccentrici. Mi occuperò cioè
di alcune figure di letterati che, in modo insolito, atipico, hanno
fatto
i conti con le forme brevi di scrittura, in particolare con
l'epigramma.
Devo premettere, prima di iniziare la mia esile rassegna
epigrammatica,
che, per non impelagarmi in questioni teoriche e definitorie del tipo:
«che cos'è un epigramma?» oppure «questo che
abbiamo
davanti è un epigramma?» o ancora «quanti modelli di
epigrammi esistono?», «gli epigrammi hanno il naso dritto,
salutano con una strizzatina d'occhi, portano i pantaloni alla
zuava»
e storie di questo genere, che, confesso subito, non sono alla portata
della mia capacità di elaborazione critica, ho quasi sempre,
salvo
qualche svolazzo o licenza poetica, fatto riferimento a testi che
l'autore
stesso o altri per lui (un critico, un amico, ecc.) ha chiamato
«epigrammi»:
dunque sulle questioni concettuali ho deciso pilatescamente di
lavarmene
le mani.
Sollevatomi dal peso di questa incombenza teorica, di questo
macigno speculativo e dottrinale, direi che possiamo cominciare.
Gli epigrammisti de il Caffè
La rivista di
«letteratura e satira» il
Caffè,
fondata nel 1953 da Giambattista Vicari, è stata una piacevole
vetrina
di epigrammisti, fra cui alcuni maestri del genere come Gaio Fratini e
Guido Ceronetti. Di quest'ultimo, non sempre si ricorda la rubrica
dall'indefinibile
titolo Nuova Vaselina Sinfonica, dove si possono leggere
scherzi
come i seguenti, caratterizzati da un'aperta propensione al calembour:
Proustituta: meretrice che
è anche lettrice di Proust.
Lisbica: lesbica libica.
Il dottor Gibaud ha una fascia da culo.
Si prega di non sbattere la potta.
Non discutiamo del cesso degli angeli.
Si deve aggiungere che
questi scrittarelli di Ceronetti,
usciti
sul numero 4-5-6 de il Caffè del 1973 (p. 27),
costituiscono
il primo nucleo di una nascente bizzarra accademia, l'«Istituto
di
Protesi Letteraria», che agirà all'interno della rivista
di
Vicari con l'intento, decisamente patafisico, di «rinnovare i
registri
della nostra letteratura», avendo a modello le sperimentazioni
messe
in atto dall'OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), gruppo
francese fondato negli anni sessanta del secolo scorso da
François
Le Lionnais e Raymond Queneau, cui accenneremo più avanti.
I primi testi, presentati esplicitamente come
«epigrammi»,
escono sul numero 2 de il Caffè del 1958 (pp. 47-48) a firma di
Giulio Alessi, classe 1916, poeta e critico letterario, che ne
pubblicherà
altri sul numero 3 del 1958 (pp. 34-36). Sono epigrammi non proprio
fulminanti,
tutti preceduti da un titolo, come questo:
SOLILOQUIO DELL'IMPIEGATO ALTO
Mentre uscivo dalla banca, con
due clienti bassi di statura
che gentilmente
mi lasciavano il passo, udii quello più piccolo mormorare: - Il
più alto è sempre il più povero.
Con l'appellativo di
«Arguzie in versi»
compaiono
altri epigrammi sul numero 10-11 del 1959 (pp. 27-35), a firma di vari
autori. Di Eraldo Miscia (1920), poeta e commediografo, ne riportiamo
due:
Il successo
Il cane odora l'altro cane
e subito capisce il sesso.
Il fiuto
è la chiave del successo.
Ultime di cronaca
Per le statistiche
contano solo le unità.
Un pescecane
vale quanto un baccalà.
Seguono quelli del poeta
Marino Piazzolla (1910), di un
Vile Anonimo
e di una certa Sara Gasco Loret, autrice di questo epigramma intitolato
«L'equivoco»:
Un tal Diogene uscì dalla
sua botte
e al Pincio si trovò: s'era di notte.
Lui se ne andava con la lanternina
quand'ecco che un agente si avvicina:
- E lei, che cerca? Dica un po', buon uomo! -
E Diogene risponde: - Cerco l'uomo. -
- Ah, brutto porco! Un altro ne ho acchiappato! -
E Diogene finì al commissariato.
Per essere esaustivi
dobbiamo poi menzionare gli
epigrammi di
Rossana Ombres (1931) (2, 1962, pp. 37-38), di Carlo Villa (1931),
autore
di romanzi di beffarda ironia sui miti e le convenzioni borghesi (3,
1965,
pp. 25-28; 5, 1967, pp. 48-49), di Attilio Steffanoni (2, 1968, p.
143),
gli «epigrammi in prosa» del filologo Ottavo Panaro (1933)
(2, 1971, pp. 110-113) e quelli «facili» di Leonardo
Castellani
(1896-1984), corredati da sette disegni dello stesso autore (11, 1974,
pp. 4-8).
Figura di bizzarro epigrammista de il Caffè
è
il colonnello Mario Zaverio (o Xavier, forma spagnola di Zaverio o
Saverio)
Rossi (1884-?), di Mirandola (Modena), autore di due testi: Apologia
dell’aplologia, un quaderno d’appunti sulla classificazione e
«codificazione
antinomenclatoria» di alcuni giochi di parole, a partire da
quello,
utilizzato dagli enigmisti italiani, che va sotto il nome di
«lucchetto»
(il gioco consiste nel togliere la parte finale a una prima parola,
l’uguale
parte iniziale a una seconda e nel fondere le parti residue formando
una
terza parola: lo schema è Ax + xB = AB; ad esempio: LUpa +
paCCHETTO
= lucchetto), e del poemetto o «carme» È morto
Massinissa,
più lungo dei Sepolcri del Foscolo, in 435
endecasillabi,
ciascuno dei quali contiene uno o più antipodi (l’antipodo
è
un gioco di parole con cui una lettera, iniziale o finale, viene
mandata
agli antipodi delle lettere rimanenti, permettendo una rilettura da
destra
a sinistra, così come accade, ad esempio, con la parola
«banana»:
portando la «b» agli antipodi di «anana»,
abbiamo
«anana-b» che, letta da destra a sinistra, dà di
nuovo
«banana» da cui si è partiti, cosa che succede anche
con il nome «M-assinissa»). Alcuni brani di È
morto
Massinissa sono stati pubblicati a più riprese dal
colonnello
(si veda in particolare: Mario Xavier Rossi, «Antipodi», L’Europeo,
26, 28 giugno 1979, p. 141, e 30, 26 luglio 1979, p. 77).
Già addetto all'Ufficio Cifra del SIM, il colonnello Rossi
è stato titolare delle cattedre di Messaggi Cifrati e di
Istituzioni
Retoriche all'Accademia Militare di Modena. Ateo e non massone,
robustamente
antifascista (bevuto l’olio di ricino nel 1921, conservò
imbottigliati
i frutti dell’affronto, e li fece trangugiare agli invecchiati
mascalzoni
nel 1945) e antimonarchico, sempre impassibile come Buster Keaton, ed
erettissimo
nella personcina (visto di spalle era tale e quale Giacomo
Debenedetti),
il colonnello vedeva un segno del destino di essere nato nel 1884, data
in cui venne pubblicato il romanzo À rebours (tradotto
in
italiano con A ritroso oppure Controccorente) di
Joris-Karl
Huysmans.
Tracce del colonnello Rossi troviamo in diversi testi di
Giampaolo
Dossena («Pseudobifronti», il Caffè, 1,
1977,
pp. 36-47; «Una macchina di antipodi con ananas e banane», Tuttolibri
La Stampa, 312, 1 maggio 1982, p. 8; Garibaldi fu ferito,
Bologna,
il Mulino, 1991, pp. 75-76).
Sul numero 4 de il Caffè del 1965 (pp. 56-70),
preceduti da una lettera di Rossi («Il culo dell'iceberg»)
indirizzata a Vicari, vengono pubblicati degli epigrammi del
colonnello,
fra cui questi:
Il Peppo
Il mio amico ed io
giocavamo alla palla sul Parnaso.
È cascata giù.
Il mio amico ed io
giocavamo a moscacieca sul Parnaso.
Il mio amico è cascato giù.
Ettore
C'era una volta un Sintomo
che si sentiva male;
faceva fatica
a fare le scale.
Diceva: «È sintomatico
che non riesco a andar su.
Ma se il fatto è sintomatico,
episodicamente,
non me ne importa niente.
La mia stanchezza è un simbolo
o almeno poco ci manca.
Una generazione stanca
si riconoscerà in me,
prima o poi,
e potrà fare più consapevolmente i fatti suoi.»
Così dicendo saliva le scale
e non si sentiva neanche più tanto male.
Parlando de il
Caffè di Vicari non si
può
non citare, fra gli esempi di scritture brevi prossimi agli epigrammi,
i «Novantanove proverbi strutturalisti» di Anonimo
ginevrino,
«omaggio implicito al grande Ferdinando», dietro il quale
si
nascondono due noti studiosi di linguistica e semiologia, che oggi
sappiamo
essere Umberto Eco e Tullio De Mauro, proverbi strutturalisti che
escono
su il Caffè, 5/6, 1972, pp. 25-28.
Sono proverbi come questi:
Chi Lacan l’aspetti.
Il Propp stroppia.
Chi struttura la vince.
Derrida bene chi scrive ultimo.
Chi non Cratilo non critica.
Vedi Peirce e Morris.
Ama la prossemica come te stesso.
Chi non fa semiologia trova le stringhe ma perde la via.
Chi lancia noemi fa scherzi da Prieto.
Se fori il referente, metti il triangolo.
Alfredo Bonelli e la «vita da libri»
Di Alfredo Bonelli, assiduo
frequentatore di scritture
brevi,
e del suo libro Scene ordinarie di vite da libri, edito da
Salvati,
con dieci tavole illustrate di Diego Ferrari, mi sono occupato in una
recensione
apparsa su Il Provvisorio. Giornale artistico, letterario e politico
del 5 maggio 2000 (pp. 10-11) (ora anche in: Paolo Albani, Il sosia
laterale e altre recensioni, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard,
2003,
pp. 75-84).
In quella recensione scrivevo che, con i suoi «epigrammi
in prosa» (così li chiama il suo autore: ricordiamo che
Mario
Andrea Rigoni ne Il pensiero di Leopardi, Milano, Bompiani,
1997,
definisce l'aforisma «una sorta di epigramma in prosa»),
Bonelli
ha voluto fare «un tenero omaggio all’energetica fragilità
dei libri, alla loro dignitosa e mirabolante sopravvivenza». Il
volume
di Bonelli, aggiungevo, «È un’apologia del libro in quanto
"oggetto d’affezione", un gioco di rimandi antropomorfici in cui il
mistero
racchiuso in un plico di fogli rilegati si fa interprete di una
quotidianità
espressiva, mai banale e rassicurante. Le "scene di vita" descritte da
Bonelli mostrano un campionario di umanità libraria che non si
lascia
corrompere dai luoghi comuni e dalle facili scorciatoie, che affronta a
viso aperto le contraddizioni di un’esistenza per molti versi
prevedibile
e già catalogata».
Le Scene ordinarie di vite da libri, che ha in esergo
questo motto di un Anonimo del XVII secolo che dice: «Un libro
è
un libro», rappresentano un caso significativo di epigrammi in
prosa
a tema unico, cioè di brevi scritti tutti dedicati a un soggetto
esclusivo, circoscritto, nel nostro caso, appunto, il libro.
Ecco alcuni epigrammi tratti dalle Scene ordinarie di vite da
libri di Bonelli:
Un libro incontrò un altro libro che nessuno aveva mai
letto
fino ad allora. Lo squadrò bene, dall’alto in basso della
costola.
Poi, con un’aria di sufficienza, gli disse: «Che intonso
sei!»
***
Un libro se ne stava sdraiato sul dorso a guardare il cielo
brulicante
di letterine luminose. D’un tratto vide cadere una letterina ed
espresse
un desiderio: «Mi piacerebbe avere una ristampa!»
***
Un libro si eccitava sognando ogni notte una copertina
diversa.
***
Un libro espose in modo così chiaro le proprie idee che
gli altri
libri presenti esclamarono: «Parli come un libro stampato!»
***
Un libro aveva un’idea fissa nel frontespizio: restare in
bianco.
***
Un facsimile vide l’originale e gli disse: «T’immaginavo
più
magro!»
Per il loro contenuto, gli
epigrammi in prosa di Bonelli
fanno
venire in mente il testo di un grande scrittore, Max Aub (1903-1972),
un
maestro di scritture brevi con i suoi Delitti esemplari (1957),
quadretti tragici e surreali di vita quotidiana, oltre che autore di un
formidabile falso letterario, la biografia di un pittore mai esistito, Jusep
Torres Campalans (1958), di cui si pubblicano anche i quadri, un
pittore
presentato come un anticipatore di Picasso, amico dei più grandi
pittori della Parigi dei primi anni del secolo.
In un testo ancora inedito in italiano, Signos de
ortografìa,
pubblicato nel 1968 sul numero 23 della Revista de Bellas Artes,
stampata in Messico, Aub racconta da «uomo di lettere»,
così
sedotto dalla perfezione formale da dichiarare: «una fanciulla
slanciata
non lo sarà mai come una lettera Bodoni», le vicissitudini
umane dei segni tipografici. E lo fa usando il respiro a lui familiare
del componimento breve. Ne nasce una piccola antologia di epigrammi in
prosa monotemaci, di cui, qui di seguito, diamo alcuni esempi nella
traduzione
di Anna Busetto Vicari.
Punti, virgole, lineette,
parentesi, asterischi: quanti
crimini si commettono
in vostro nome!
Impalarlo in un punto esclamativo!
Camminava zoppo per un richiamo a piè di pagina.
Morì per un capolettera messo di traverso.
Gli cadde un asterisco e camminò piegato per tutta la vita.
Punto e a capo: la decapitazione.
Chiamavano quella povera prostituta «La postilla».
Com'è noto Learco
Pignagnoli ha scritto, fra le
altre cose,
dei Racconti brevissimi e dei Racconti così brevi
che
più brevi non si può, entrambi usciti su Il
semplice,
rispettivamente sul numero 1, 1995 (pp. 129-131) e sul numero 5, 1997
(pp.
114-118). Un cenno alla produzione micronarrativa di Pignagnoli si
trova,
a testimonianza dell'interesse che la sua figura ha suscitato anche in
ambito accademico, in un recente saggio di Gino Ruozzi (si veda Gino
Ruozzi,
«Forme proprie e improprie dell'aforisma nella tradizione
letteraria
italiana» in: Giulia Cantarutti, La scrittura aforistica,
Bologna, il Mulino, 2001, pp. 161-197). Sulla figura e le opere di
Learco
Pignagnoli, scrittore e filosofo, si è tenuto un convegno,
organizzato
da Daniele Benati e Ermanno Cavazzoni, presso la Fondazione Collegio
San
Carlo di Modena durante l'edizione 2003 del Festival della Filosofia.
A ben vedere gli epigrammi di Pignagnoli sono da considerarsi
più correttamente come delle «forme improprie» di
epigrammi,
per usare la terminologia ruozziana (si veda il già citato
saggio
di Ruozzi), nel senso che gli epigrammi del Pignagnoli non nascono come
epigrammi intenzionali, voluti, deliberati, ma sono più che
altro
frasi occasionali, battute, pensieri sciolti, considerazioni sparse
raccolte
da altri in diversi contesti e periodi e successivamente riuniti in un
libretto curato da Orazio Tagliaferro, che fu a lungo amico intimo del
Pignagnoli. Nell'introduzione, Tagliaferro definisce
«epigrammatiche»
alcune «sentenze pignagnolesche».
Dal libro del Tagliaferro traggo questi brani:
Alcuni amici di Pignagnoli
raccontano che Pignagnoli andava
spesso dal
dentista o dall’urologo, anche se non ne aveva bisogno, solo per
leggere
quei settimanali scandalistici che si trovano nelle sale d’aspetto dei
medici - Chi è?, Il Sabato e la Domenica dei vip, Dietro le
quinte,
La TV fra sorrisi e palloni - che in edicola Pignagnoli si vergognava a
comprarli. Prendeva spunto dalla lettura di quei giornaletti per
scrivere
aforismi sul tema dell’invidia, della morte e su altri ancora.
La seconda moglie di Pignagnoli
confidò a un’amica che
il marito
aveva l’abitudine, un attimo prima di mettersi a tavola, di leggere a
voce
alta, con una certa enfasi, il titolo di un articolo della Gazzetta
dello
Sport, come se fosse stato l’incipit di una poesia. Le rivelò
anche
che Pignagnoli perse quell’abitudine quando Felice Gimondi si
ritirò
dalle corse. Una volta, sempre a stare al racconto della sua seconda
moglie,
Pignagnoli, prima di leggere il titolo di un articolo della Gazzetta
dello
Sport, si lasciò andare a questa considerazione: «La
poesia
è come la barbabietola, il meglio sta sotto». [Faccio
notare
che l'affermazione del Pignagnoli assomiglia molto a quello di Achille
Campanile: «Gli asparagi sono come gli epigrammi: tutto il buono
è nella punta», che forse Pignagnoli non conosceva].
È un particolare risaputo
che, in certe occasioni (di
solito
quando aveva bevuto del tamarindo o dopo una partita a bocce),
Pignagnoli
si abbandonava a un suo personale, arabizzante modo di scrivere: gli
succedeva
di srotolare le parole da destra verso sinistra. Così, se doveva
scrivere la frase: «La curva è pericolosa, ma
bella»,
la componeva sul foglio partendo da «alleb» e la finiva con
«aL». Diceva che scrivere in quel modo gli ricordava lo
sforzo
eroico di quando si affrontano le salite in bicicletta. Sempre alla
rovescia
si divertì a scrivere questo pensiero tristissimo, a suo modo
denso
di significati: «Se il mio cane sapesse che un giorno
morirà,
mi chiederebbe più crocchette».
Da bambino Pignagnoli si
arrampicava come uno scoiattolo sopra
i peschi
allineati su cinque file nel campo dello zio, e da lì gli
piaceva
sputare il nocciolo delle pesche sulla testa dei bambini che giocavano
sotto di lui. Un giorno la mamma se ne accorse e lo sgridò:
«Learco,
non si fa così». Allora lui, impermalito, salì di
nuovo
sopra un pesco e sputò su una bambina la polpa della pesca
macchiandole
il vestitino, che le macchie di pesca sono difficili da togliere. Da
grande,
il ricordo di quell'episodio gli suggerì questo pensiero:
«Le
donne quando vogliono sono proprio delle grandi rompicoglioni».
Si dice che una volta, osservando
il mare dalla terrazza della
Pensione
Eden, a Zadina Pineta sulla costa adriatica, Pignagnoli se ne
uscì
con questa attenta riflessione (ripresa anche in una sua poesia):
«Se
il mare fosse piccolo non sarebbe più il mare».
Un pomeriggio, mentre in camera
da letto svitava una lampadina
fulminata
da uno dei bracci ricurvi del lampadario, Pignagnoli cadde dallo scaleo
e si ruppe la gamba destra. Lo ingessarono fin sopra al ginocchio e sul
gesso, come risulta dalla testimonianza della sorella, scrisse a
caratteri
minuscoli questa frase: «C'è più musica in uno
starnuto
che in tutte le sinfonie di Beethoven». Dopo quaranta giorni gli
tolsero il gesso, che fu buttato via, dentro il raccoglitore dei
rifiuti
inorganici dell’ospedale, insieme alla frase del Pignagnoli, che
infatti
non figura in nessuno dei suoi testi.
Finito il liceo, Pignagnoli
avrebbe voluto iscriversi alla
Facoltà
di Ingegneria di Bologna, ma non lo fece, perché, al momento
dell’iscrizione,
si rifiutò di compilare la domanda su cui c'era scritto:
«Al
Magnifico Rettore». «Io neanche lo conosco il
rettore»
disse Pignagnoli all’impiegata della segreteria studenti della
Facoltà
di Ingegneria. «Magari è brutto come un rospo, altro che
magnifico!»
Mentre stracciava il foglio dell’immatricolazione, in molti lo
sentirono
bofonchiare questa massima: «Dietro le loro cattedre imponenti, i
professori universitari si fanno delle grandi pugnette!»
Una volta, a Cavriago, vicino a
Reggio Emilia, mentre, su un
lato della
strada, vedeva sfilare i corridori del Giro d'Italia, belli sudati e
vigorosi
con le loro magliette colorate aperte sul petto, Pignagnoli si commosse
e formulò questo pensiero: «Nella coscia di un ciclista
c'è
tanto di quel muscolo che basterebbe a sfamare più di cento
gatti
randagi!»
Vorrei sottoporvi un
piccolo esercizio di filologia
incauta. Nel
suo Manuale di poesia (Parma, Guanda, 1995), Giuseppe Conte
sostiene
che l'epigramma «è un componimento le cui caratteristiche
essenziali sono la brevità, la ricerca di una chiusura
sorprendente,
il secco tono aforismatico, quello di denuncia, quello del sarcasmo, la
condensazione erotica».
Lo stesso concetto ritroviamo nell'«Introduzione»
agli Epigrammi italiani. Da Machiavelli e Ariosto a Montale e
Pasolini
(Torino, Einaudi, 2003) quando Gino Ruozzi scrive: «Là
dove
c'è veleno e brevità molto probabilmente c'è un
epigramma;
che diventa ancora più efficace se è accompagnato da
inversioni
e chiuse impreviste (le acutezze). Sta forse nel fattore sorpresa la
differenza
con le satire; nel senso che anche l'epigramma appartiene in moltissimi
casi al vasto mondo della satira [...]; ma l'elemento sorpresa, il
finale
ben riuscito, dovrebbe costituire un punto d'orgoglio e distintivo, per
usare il criterio magistralmente indicato da Lessing nelle sue note
osservazioni
sull'epigramma (Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm, und
einige
der vornehmsten Epigrammatisten, 1771)» (p. XVIII).
Dunque, seguendo questa linea interpretativa che va da Lessing
a Ruozzi passando per Conte, credo non sia un azzardo annoverare nel
genere
«epigramma», testi come quelli che seguono, maledettamente
brevi, sarcastici e tutti giocati da «chiuse impreviste»:
Tu non sai cos'è la vita,
tu non sai cos'è l'amore,
tu non sai cos'è un sorriso...
Mi sono messo con una deficiente.
Come Beatrice per Dante,
come Laura per Petrarca,
come Silvia per Leopardi,
così sei tu per me amore...
Una stronza che si rifiuta di darmela!
Sento le tue mani sul mio corpo,
sento le tue mani sul mio viso,
sento le tue mani sulle mie labbra...
Che due maroni la mosca cieca!
Che poi, come si
sarà capito, sono le poesie di
Flavio
Oreglio, poeta non proprio sublime, tratte dal suo libro Il momento
è catartico (Milano, Mondadori, 2002).
Una volta Umberto Eco si
è occupato degli autori
di quarta
dimensione, quelli che pubblicano a proprie spese (cfr. Umberto Eco,
«L'industria
del genio italico», in: Valerio Riva, a cura di, L’Espresso
1955/85.
30 anni di cultura, Roma, Editoriale L’Espresso, 1985, pp. 29-47; e
anche in «Varia et Curiosa. Storia dei fous
littéraires», L'esopo,
89-90, marzo-giugno 2002, pp. 9-32).
Il termine «quarta dimensione» rientra in una
classifica,
retta da criteri sociologici e non valutativi, in cui, secondo Eco,
può
essere suddiviso il mondo letterario. Esiste una prima dimensione
letteraria
che è rappresentata dal manoscritto (non di rado alle case
editrici
arrivano «testi di quattrocento pagine inviati da colonnelli in
pensione
per dimostrare che la teoria della relatività è falsa,
che
Newton ha sbagliato le sue formule», ecc.); la seconda dimensione
è quella delle riviste e dei libri, pubblicati da editori
più
o meno grandi e noti; la terza dimensione è quella del libro di
successo, recensito e tradotto all’estero, ristampato a più
edizioni
in patria; c’è infine la quarta dimensione che accoglie quei
testi
che non passano dalla prima alla seconda dimensione e si regge sul giro
d’affari di un editore sconosciuto che pubblica facendosi elargire un
contributo
finanziario dall’autore. «Chi entra nella quarta dimensione
letteraria
può trascorrere una vita felice, attorniato da lettori, onorato,
se non da discepoli, da amici e parenti devoti, in fitta corrispondenza
culturale e affettiva coi propri simili, da un capo all’altro d’Italia.
Come un esercito di “alieni” scesi da un altro pianeta per vivere
accanto
a noi, come comuni esseri umani, essi ci sfiorano ogni giorno: sono il
pensionato seduto ai giardini, l’impiegato di banca che ci ritira
l’assegno,
la signora del pianerottolo accanto. Sono, rispetto agli scrittori
della
seconda dimensione, novantanove contro uno. Sono, statisticamente
parlando,
l’ossatura del costume letterario italiano» (Umberto Eco,
«L'industria
del genio italico», op. cit., pp. 32-33).
Al tema degli autori di quarta dimensione (portatori di
manoscritti
che vorrebbero pubblicare con editori seri) è rivolto il libro
di
Fabio Mauri I 21 modi di non pubblicare un libro, Bologna, il
Mulino,
1990, che, guarda caso, ha una prefazione di Eco.
Perché ho accennato agli autori di quarta
dimensione?
Perché ho scovato, per caso, sfogliando uno schedario
a soggetto della Biblioteca Nazionale di Firenze, un tipico esemplare
di
autore di quarta dimensione, un certo Attilio Canaletti, poeta
grossetano,
agricoltore di professione e animalista per passione, fondatore nel
1951
dell'«AAVV - Associazione Amici dei Volatili e Vegetali»
(come
si legge nella sua nota biografica), che ha pubblicato nel 1956, a
proprie
spese, presso la tipografia dei fratelli Marini di Grosseto, un
libretto
contenente 134 epigrammi, da lui chiamati «ruspanti»,
perché
interamente dedicati alla gallina, animale domestico vittima, come si
sa,
di ingenerosi luoghi comuni. Leggendo gli Epigrammi ruspanti
del
Canaletti non si può fare a meno di pensare alle deliziose
storielle
raccontate da Luigi Malerba ne Le galline pensierose (1980), o
alla
famosa canzone di Cochi e Renato.
Gli epigrammi del Canaletti, metricamente non omogenei (oscillano
dai due ai quattro versi), tutti rigorosamente in rima (gli schemi
ricorrenti
sono ABBA e ABAB), si risolvono in un divertente capovolgimento dei
ruoli,
dove il confronto fra l'umanità della gallina e la
stupidità
dell'uomo (specie l'uomo politico) ha il sapore di un'amara denuncia,
vagamente
ispirata a idee socialisteggianti.
Ecco alcuni «epigrammi ruspanti» del Canaletti:
La osservo quando becca e
saltabella
fra i sassi e le zollette di un prato riposante.
Mi accorgo allora in quell'istante
che la gallina è tenera perché non si arrovella.
Nell'animo di una gallina
c'è un fondo di vera umanità.
Lo sguardo poi alla mattina
è quello di un politico che parla di onestà.
Ad ogni età la gallina
ripete il suo verso
spargendo nell'aria allegri: «Coccodè,
coccodè»,
mentre l'uomo che da vecchio si sente perso
sospira tristemente: «Povero me! Povero me!»
La gallina in sé non
coltiva
il mito del danaro esoso.
L'amicizia nel pollaio per lei giuliva
è il bene più prezioso.
Una gallina fa le uova regolari
nei giorni di lavoro e delle messe.
Zelante mantiene le sue promesse
non come i più dei nostri parlamentari.
Se una gallina si mettesse a
scrivere
di certo impiegherebbe le sue penne.
E forse comporrebbe versi in modo più solenne
di tanti poetastri afflitti dal mal di vivere.
La gallina rifugge gli slanci
spirituali
non si è inventata come l'uomo un al di là.
Lei crede solo nella propria gallinità
essendo la più laica fra tutti gli animali.
Sandro Dorna, classe 1938,
è giornalista (ha
collaborato
con La Stampa, L'Europeo, Il Giornale dell'Arte,
la
RAI) e autore di testi giocosi come l'Anagramma è gioco tosto,
presentato da Umberto Eco (il titolo è l'anagramma dell'editore:
Gaetano Mastrogiacomo di Padova, 1978); C'è l'arte non liscia,
presentato da Giampaolo Dossena (Torino, Martano, 1981); Acrostici
anagrammati,
presentato da Saverio Vertone (Torino, L'uovo di Struzzo, 1992) e Che
cos'è l'arte, presentato da Ugo Castagnotto (Torino, Umberto
Allemandi, 1994).
Nel 1998, presso l'Edizioni L'Obliquo di Brescia, Dorna pubblica
un libretto intitolato, con un gioco di parole fonetico, J'ai des
mots.
Si tratta di una raccolta di epigrammi che sfruttano con grande
abilità e inventiva le ambiguità del linguaggio, gli
slittamenti
di significato, a volte al limite di quello spaesamento che ci
procurano
le crittografie mnemoniche (mezzo minuto di raccoglimento: il
cucchiaino).
Nella prefazione, Giuseppe Pontiggia definisce Dorna un
«cacciatore
di parole... che ha imparato a osservarle controluce e a moltiplicarne
i significati ottici variando la messa a fuoco dei pieni e dei vuoti
[...]
Dorna ama [...] entrare nei negozi di oggetti usati, di proverbi
arruginiti,
di luoghi comuni. Li scruta da ogni parte, li capovolge. Sembrano
inservibili,
li acquista a poco prezzo. E invece a caro prezzo - di lavoro e di lima
- li rende rilucenti». A proposito di un epigramma di Dorna:
«Nessuno
può riparare / una perdita di tempo», che sembra un
omaggio
a Seneca delle Lettere a Lucilio, Pontiggia osserva: «Forse
è
questa la radice dell'amore per la brevitas».
Vediamo alcuni epigrammi del Dorna:
Pazientate,
il tempo libero passa.
Il metro di giudizio
non è mai lineare.
La donna si realizza
quando è colta.
Ogni vano
è utile.
È impossibile stare al
passo
con i tempi che corrono.
Una violenta passione
può mettere in croce.
Gli uomini desiderano
molte donne perché una
è troppo.
Il «limericco» italiano e dintorni
Parenti stretti
dell'epigramma sono il limerick,
l'«incarrighiana»
e la «clerihew».
Il limerick è una poesiola nonsensica in cinque versi,
con uno schema ben preciso (il primo, il secondo e il quinto verso
rimano
fra loro, mentre il terzo verso rima con il quarto), di ritmo
giambico-anapestico,
contenente in genere nel primo verso il riferimento a un luogo
geografico.
I limericks (per alcuni la parola deriva da Limerick,
città
irlandese, famosa per l'assedio del 1690-91 di cui parla Laurence
Sterne
nel Tristram Shandy) furono resi famosi da Edward Lear (1812-1886),
pittore,
insegnante di disegno della regina Vittoria. In realtà, come
precisa
Dossena, Lear «non scrisse veri limerick (cose da osteria,
volgari
e sensate), ma dei nonsensi, che hanno la forma del limerick ma
argomenti
e toni ben diversi» (Giampaolo Dossena, «Limerick»
voce
dell'Enciclopedia dei giochi, 3 voll., Torino, Utet, 1999).
Da Il libro dei nonsense (Torino, Einaudi, 1970) ecco
un limerick di Lear nella traduzione di Carlo Izzo:
C'era un vecchio di Caltagirone
Con la testa non più grande d'un bottone;
Quindi, per farla sembrare più grande,
Comperò una parrucca gigante
E corse su e giù per Caltagirone.
Hanno scritto dei limericks
scrittori come Lewis
Carroll,
Robert Louis Stevenson, James Joyce e anche il filosofo, premio Nobel
per
la letteratura (nel 1950) Bertrand Russell. Sembra ci sia un limerick
citato fra i versi de La terra desolata di T.S. Eliot (T.S.
Eliot, La
terra desolata, Torino, Einaudi, 1963, p. 31).
Il limerick è la più popolare delle forme
epigrammatiche inglesi. Lo dice anche l'Encyclopaedia Britannica del
1951 dove si legge che «Il limerick è [...] un tipo di
epigramma
licenzioso che passa di bocca in bocca più spesso sussurrato che
cantato».
Dopo le traduzioni delle poesie di Lear ad opera della Camilla
Poggi Del Soldato (verso il 1930 per l'Enciclopedia dei Ragazzi),
di Carlo Izzo (1935, 1945 e 1970) e di Mario Praz (1938), in Italia il limerick
raggiunge
una certa popolarità con il Giro d'Italia in limericks
promosso
dai «Wutki» sulla rivista Linus negli anni
1972-1974.
«Wutki» (che fu un pittore svizzero) è il nome della
rubrica di giochi diretta da Sergio Morando (1923-1982), che è
stato
condirettore editoriale alla Bompiani, assieme a Paolo De Benedetti (di
cui parleremo fra poco) e a Umberto Eco, passato poi alla Garzanti e a
Mondadori. Nel 1966 Morando cura l'Almanacco Letterario Bompiani
dedicato al gioco, che contiene un bellissimo saggio di Paolo De
Benedetti
sulla «Letteratura nonsensica» (ora anche in Paolo De
Benedetti, Nonsense
e altro, Milano, Libri Scheiwiller, 2002, pp. 104-128).
In quegli anni i Wutki scoprono che i limericks sono
«una
passione italiana latente», ne arrivano tantissimi in redazione,
qualcuno, come Luciano Marchesini di Torino, ne manda 100. Su Linus
compare anche un limerick del colonnello Mario Zaverio Rossi,
di
cui abbiamo visto alcuni epigrammi usciti su il Caffè di
Vicari:
Fra i poliglotti bagnanti di Spa
sono frequenti freddure comme ça:
Il contrario di abbondantemente
(leggi: A Bonn Dante mente)
è che a Berlino Petrarca dice la verità.
e viene ripubblicato un epigramma
di Luigi Compagnone
(1915-1998) che
«sarebbe anche potuto passare per un limerick»:
C'era un vecchio lettore di
Ferrara
che la sua città aveva assai cara.
Lesse Bassani e la sentì più cara.
Se lo rilesse, e si ordinò la bara
stufo ormai di Bassani e di Ferrara.
In effetti, la sezione
«Nonsense» del libro
di Compagnone Che
puzo! Epigrammi e Nonsense, Milano, All'insegna del Pesce d'Oro,
1973,
pp. 67-82, è formata da composizioni poetiche che hanno la forma
del limerick, tanto per rimarcare una certa vicinanza tra
epigramma
e limerick (sul «limericco» italiano si veda
Carmine
De Luca, «Limerick all'italiana», LG argomenti,
rivista
del Centro studi di letteratura giovanile di Genova, 1, gennaio-marzo
1993).
Uno dei primi autori italiani di limericks è
Giuseppe
Isnardi, nipote dell'ingegnere Giovenale Gastaldi che costruisce per
Lear
prima villa Emily e poi villa Tennyson a Sanremo. Quando Lear muore,
Isnardi
ha soltanto due anni, quindi non ha avuto modo di conoscerlo:
ciò
nonostante da grande scriverà su Lear, ne tradurrà i Diari
di viaggio in Calabria e nel Regno di Napoli, ma soprattutto
comporrà
lui stesso - «austero storico e pedagogo, collaboratore de La
Voce come della Società geografica italiana» - decine
di limerick come il seguente:
C'era una giovane donna di Roma
che portava disciolta una gran chioma.
Tutte le volte che il vento soffiava
lieta e felice pe 'l cielo volava
questa gentile fanciulla di Roma.
Un altro autore italiano di
limericks è
Paolo De
Benedetti, direttore editoriale, biblista, consulente di molte case
editrici.
Mi piace ricordare che De Benedetti è uno dei principali
biblisti
italiani, docente di Giudaismo presso la Facoltà Teologica
dell'Italia
Settentrionale di Milano e di Antico Testamento presso gli Istituti di
Scienze Religiose delle Università di Urbino e Trento. Tra i
suoi
scritti: La morte di Mosé e altri esempi (1978), La
chiamata
di Samuele (1976), Ciò che tarda avverrà
(1992), Quale
Dio? (1997), Introduzione al giudaismo (2001).
Recentemente,
presso le Edizioni San Paolo di Milano, ha pubblicato una raccolta di
poesie
intitolata Gattilene.
De Benedetti è l'artefice del più lungo poema in limerick,
cioè il Viaggio in Limerick sul Reno e dintorni / dai Paesi
Bassi
alla Svizzera / con osservazioni storiche & geografiche / &
pittoriche
& una incarrighiana morale / di due ill.mi Dottori dell'Ambrosiana
(1957) (ora in Paolo De Benedetti, Nonsense e altro, Milano,
Libri
Scheiwiller, 2002, pp. 19-25). L'altro ill.mo Dottore è Mario
Spagnol
(1930-1999).
L'«incarrighiana» è una poesia in ottonari
che prende il nome da Ferdinando Incarriga (o Ingarriga), giudice
napoletano
alla Gran Corte criminale nel Palazzo di Giustizia di Salerno, che nel
1834 a Napoli dette alle stampe l'Opuscolo che contiene la raccolta
di cento anacreontiche su di talune scienze, belle arti, virtù,
vizj, e diversi altri soggetti. Queste anacreontiche, poi chiamate
Incarrighiane, sono poesie di comico involontario con strane acrobazie
verbali e spesso con l'ultimo verso apocopato, che si prefiggono di
dare
delle definizioni. Il libro ebbe molto successo, se ne vendettero molte
copie, anche perché i parenti dell'Incarriga ne comprarono di
nascosto
numerose copie per sottrarre dal ridicolo il loro congiunto.
Ecco una tipica «incarrighiana»:
L'astronomia
Stronomia è scienza amena
Che l'uom porta a misurare
Stelle, Sol e'l glob' Lunare,
E a veder che vi è là sù.
Quivi giunto tu scandagli
Ben le Fiaccole del Mondo
L'armonia di questo tondo
Riserbata a Dio sol' è.
Molto simili alle
Incarrighiane si presentano certe
strofette
di Ettore Petrolini (1884-1936):
È la moglie quella cosa
che per lusso e per vestito
spende il doppio del marito
e si chiama la metà.
Ma torniamo al De Benedetti
e vediamo alcuni suoi
limericks:
C'era un vecchio di Lambrugo
che mangiava pane e sugo
quando n'ebbe pien lo stomaco
si pentì e si fece monaco,
quell'ascetico vecchio di Lambrugo.
C'era un uomo dell'Unesco
che teneva il burro in fresco
da spalmare sul paese
dove scoppiano contese,
quel pacifico uomo dell'Unesco.
Fra gli autori italiani di limerick
troviamo
anche Gianni
Rodari (1920-1980) che nella Grammatica della fantasia.
Introduzione
all'arte di inventare storie (Torino, Einaudi, 1973) dedica un
capitolo
alla «Costruzione di un "limerick"» (pp. 43-45). Nel suo
saggio
Rodari cita lo studio di due semiologi sovietici T.V. Civ'jan e D.M.
Segal
«Struttura della poesia inglese del nonsense (sulla base dei
limericks
di Lear)» in I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico,
a cura di Remo Faccani e Umberto Eco, Milano, Bompiani, 1969, studio
che
«aprirà le porte al limerick di massa», come afferma
Pier Paolo Rinaldi nel saggio «Un girotondo intorno al limerick
(bambini
e vecchi, semiologi e illustratori, poeti, poetesse e maghi)» in:
Max Manfredi e Manuel Trucco, Il libro dei Limerick. Filastrocche,
poesie
e nonsense, con prefazione di Stefano Bartezzaghi, Milano,
Vallardi,
1994, pp. 143-246. Questo di Rinaldi è uno dei saggi più
importanti sull'arte del limerick uscito in Italia (dello
stesso
Rinaldi si veda anche Il piccolo libro del nonsense, sempre con
prefazione di Stefano Bartezzaghi, Milano, Vallardi, 1997).
Ecco due limericks di Rodari:
Un signore molto piccolo di Como
una volta salì in cima al Duomo
e quando fu in cima
era alto come prima
quel signore micropiccolo di Como.
Una volta un dottore di Ferrara
voleva levare le tonsille a una zanzara
L'insetto si rivoltò
e il naso puncicò
a quel tonsillifico dottore di Ferrara.
Un limerick,
composto in inglese, compare anche
nel Maramao
(Milano, Longanesi, 1989, p. 108) di Guido Almansi (1931-2001):
There was a young girl from
Vancouver
Whose portrait now hangs in the Louvre.
Her name was Theresa, but became Mona Lisa
By means of a clever manoeuvre.
[C'era una giovane di Vancouver
il cui ritratto è appeso al Louvre.
Si chiamava Teresa, ma divenne Monna Lisa
con astute manovre. ]
accanto a una serie di clerihews,
quartine umoristiche
senza
un metro preciso su un personaggio noto, che prendono il nome dal loro
inventore, il giornalista e scrittore inglese di gialli Edmund Clerihew
Bentley (1875-1956):
Dante
Dante
Era molto arrogante.
Di parlare coi santi assumeva il diritto.
Solo col Padre Eterno è stato un poco zitto.
Ugo Foscolo
Ugo Foscolo
Era proprio un discolo
Quando scriveva un sonetto
Imperfetto.
Giorgio Bassani
A Giorgio Bassani
Non piaccion punto i nani.
Gli ricordan, quegli omini,
L'autore dei Finzi Contini.
Nel 1994 Max Manfredi
(1956), cantautore (discografia: Le
parole
del gatto 1990; Max 1994 che ospita Fabrizio De
André; L'intagliatore
dei santi 2001) e Manuel Trucco, che spero non sia l'Ambasciatore
cileno
negli Stati Uniti al tempo di Pinochet, hanno fatto «Il giro del
mondo in 320 limerick», ne Il libro dei Limerick.
Filastrocche,
poesie e nonsense, Milano, Vallardi, scrivendo limericks
seducenti,
tragici, conviviali, titanici, felici, litigiosi, gastronomici, gotici,
clericali, filosofici.
Il libro di Manfredi e Trucco si apre con dei limericks
autoreferenziali, nel senso che parlano del limerick:
Il limerick, t'educe il
dizionario,
è filastrocca d'argomento vario
che, con ritmo anapestico
vale a farti domestico
un mondo parallelo e immaginario.
Il limerick sta all'arte e alla
poesia
come bruschetta alla gastronomia.
Ma l'agile sua metrica,
come un'abile ostetrica,
aiuta i parti della fantasia.
Il limericco e il lucido
epigramma
son figli, in fondo, della stessa mamma.
Papà non è lo stesso
Più evasivo e più fesso
il nostro. Ma possiamo farne un dramma?
Per quanto ci consta,
«limericco» è
termine
coniato da Stefano Bartezzaghi, come forma italianizzata di limerick
(più avanti vedremo altre traduzioni o meglio
«mistraduzioni»
di questa parola inglese), nella «Prefazione» a Il
libro
dei Limerick di Manfredi e Trucco.
Nella sua raccolta di Canzoni politiche (Milano,
Feltrinelli,
2000), Michele Serra ha inserito dei «limericks
elettorali»:
C'è una festa aziendale al
Lingotto
con Agnelli e Cipputi a braccetto.
La sinistra fa il sunto
del successo raggiunto:
ha prevalso per solo una Punto.
C'era un seggio abusivo a San
Marco
allestito con mezzi da sbarco:
niente urne né schede
e un blindato per sede
di quel seggio di piazza San Marco.
C'era un giovane di Bardolino
che puliva il suo mitra col vino.
Ma provando il mirino
già sentiva quel guappo
che lo sparo sapeva di tappo.
Altri limericks, un
po' irregolari perché
di sei
versi, Serra aveva presentato in Poetastro. Poesie per incartare
l'insalata
(Milano, Feltrinelli, 1993, alle p. 56 e pp. 68-78):
Questione senile 1
Un povero vecchietto di
Platì
fedele nelle urne alla diccì
si vide dimezzare la pensione
e pianse per la gran disperazione.
Tra qualche mese rivoterà diccì
quel vecchio idiota nel seggio di Platì.
Questione senile 2
Una studiosa di storia della Cina
seduta in un salotto di Cortina
nel sessantotto sgridava chi non fosse
d'accordo con le grandi guardie rosse.
Adesso sgrida la colf che col piumino
ha rotto un vaso prezioso di Nanchino.
Si è detto che in
origine il limerick
è un
epigramma licenzioso. Su questo versante famosi sono quelli composti
dallo
scrittore inglese Norman Douglas (1868-1952) che nel 1928
pubblicò
a Firenze Some Limericks: Collected for the use of Students, &
Esplendour'd
with Introduction, Geographical Index, and with Notes Explanatory and
Critical.
Questa raccolta, con il titolo Certi limerick, è stata
pubblicata
nel 1990 dall'Alessandra Carola Editrice di Napoli, con testo a fronte
inglese, tradotta e curata da Benito Iezzi, con una nota introduttiva
di
Aldo Busi.
Ecco un limerick di Douglas nella traduzione di Giorgio
Weiss:
C'era un giovin idraulico di
Harare,
che pompava una tizia in riva al mare.
«Ferma quel che stai facendo:
c'è qualcun che sta venendo!»
«Son io!» pompando disse quel di Harare.
Di tipo decisamente erotico
sono le 366
«limèriche»
(una al giorno, compreso l'anno bisestile, 46 in più di quelli
di
Manfredi e Trucco), poesie nonsensicali contenute nel libro di un certo
Sergio Sesto Serpillo dall'inequivocabile titolo Che Dio la
benedica!
(Valentano, Scipioni, 2001), che ha un saggio introduttivo di Giorgio
Weiss,
anch'egli autore di limericks sul tema delle nuvole, apparsi
sul
numero 14 della rivista La Corte del 1992.
Recentemente, per via di alcune recensioni di «libri
immaginari»
che apparvero su una rubrica intitolata «Equilibri» de il
Caffè di Vicari, sono entrato in contatto epistolare con
Pier
Francesco Paolini, scrittore, anglista e traduttore, che, donandomi il
licenzioso libretto di «limèriche», mi ha svelato di
essere lui quel tal Sergio Sesto Serpillo.
Ecco tre «limèriche» del Paolini-Serpillo:
C'era un Ottuagenario in quel di
Trento
Che scopava soltanto a lume spento.
All'Amante un po' offesa
spiegava, a sua difesa:
"Perché la terza, sai, la faccio a stento."
C'è un Famoso Tenore di
Racalmuto
che, quando gode, gli scappa un acuto
dal culo - in do maggiore.
Per le donne è un onore
udir quel do di peto a Racalmuto.
C'era una volta un Principe di
Odessa
che il bacio di una bella Principessa
tramutò in un Ranocchio.
Lei allora, in ginocchio
se lo ficcò ridendo nella Fessa.
Nell'ultimo paragrafo della
postfazione ai Limericks
di
Edward Lear, pubblicati nel 2002 nella «Collezione di
Poesia»
dell'editore Einaudi, il curatore e traduttore, Ottavio Fatica, ha
riportato
una «lima ricca» indirizzata a se stesso:
C'è un poeta che faccio
fatica
A tradurre, che vuoi che ti dica,
Si tiene per savio
Ma è solo un ottavio
Di poeta, e non senza fatica.
Un'ultima curiosità
bibliografica. Nel già
citato
saggio «Un girotondo intorno al limerick», Pier Paolo
Rinaldi
cita il libro di Giampaolo Dossena Luoghi letterari. Paesaggi,
opere
e personaggi (Milano, Sugar, 1972, poi Milano, Edizioni Sylvestre
Bonnard,
2003) che si apre, nel primo luogo letterario preso in considerazione,
cioè Abano Terme (Padova), con questo limerick, datato
1955
e successivamente attribuito a Sergio Morando:
C'era un vecchio goloso di Abano
le cui figlie coi Turchi folleggiavano
inventando sempre nuove tecniche erotiche
però mangiando unicamente cotiche:
il che stupiva quel vecchio di Abano.
La voce «Abano
Terme» è interamente
dedicata
da Dossena al limerick, su cui ritorna anche discorrendo di
altre
città. Fra le altre cose, Dossena pubblica alcune prove di Gian
Carlo Cabella, come questa:
C'era un vecchio quadrivio a Novi
Ligure
ove ogni notte stazionava un Lèmure
che, non avendo spiccioli da spendere,
le sigarette si faceva accendere
dai nottambuli, rari a Novi Ligure.
Questo, come altri limericks
di Cabella
riportati nel libro
di Dossena (si veda Novi Ligure e Piovera, in provincia di Alessandria;
Ronco Scrivia in provincia di Genova; Vobarno in provincia di Brescia),
sono tratti dal libro Tuctitalia in limericks dello stesso
Cabella
pubblicato nel 1964 a Pasturana (Alessandria) presso la Tipografia
Artigiana.
Ora, se vi venisse voglia di ricercare il libro di Cabella nelle
biblioteche
o presso i più accreditati librai d'antiquariato, vana
risulterebbe
l'impresa...
[...]
Una divagazione sulla brevità
Commentando il saettante
epigramma di Franco Fortini:
«Carlo
Bo. | No.», contenuto ne L'ospite ingrato secondo (Casale
Monferrato, Marietti, 1985), Giorgio Bertone scrive: «Carlo Bo in
realtà è il titolo; dunque il monosillabo "No" è
la
più breve poesia italiana e forse il più breve epigramma
mai concepito; che sia inoltre una negazione su rima tronca, 'comica',
s'addice perfettamente alla struttura e al genere in questione» (Breve
dizionario di metrica italiana, Torino, Einaudi, 1999).
Ora, se è innegabile che l'epigramma di Fortini è
breve, anzi brevissimo, bisogna dire che, nel vasto panorama della sua
produzione letteraria, si tratta di un episodio isolato, di un fenomeno
eccezionale, di un gesto irripetibile. A differenza di Fortini,
c'è
invece un poeta, Saverio Ascari di Canossa, un paese vicino a Reggio
Emilia,
che ha composto poesie tutte rigorosamente di una sola parola. Ce
n'è
una, ad esempio, che s’intitola «Colore» e fa: Blu.
Un’altra
che ha per titolo «Cavallo» recita così: Animale. In
un’altra ancora, intitolata «Elettrodomestico», si legge:
Frigorifero
oppure Televisione. Del poeta Saverio Ascari si è occupato
criticamente
il professor Guarini, com'è documentato nel libro Silenzio
in
Emilia di Daniele Benati (Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 30-41).
Se le poesie di Ascari sono monovocaboliche,
quelle di
Luis Felipe
Pineda si condensano in un solo verso. Diligentemente custodite in un
«Archivio
di poesie abbandonate», ecco alcuni dei componimenti di Pineda:
Amo il twist della mia sobrietà.
Sarebbe fantastico essere come gli altri.
Non dirò che un rospo sia.
Una volta Pineda scrisse su
una cartina questa poesia:
«La
stupidità non è il mio forte»; poi arrotolò
la cartina trasformandola in una sigaretta che si fumò
tranquillamente.
Quando ebbe terminato di fumarsi la sua poesia disse sorridendo:
«L'importante
è scriverla» (Enrique Vila-Matas, Bartleby e compagnia,
Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 125-132).
[...]
HOME
PAGE TèCHNE RACCONTI POESIA
VISIVA
ENCICLOPEDIE
BIZZARRE ESERCIZI
RICREATIVI NEWS
|