|
CON L'OPLEPO LA LETTERATURA SI DÀ UNA REGOLATA La storia inizia nel novembre del 1990 quando, su una delle isole più belle d’Italia, due francesisti, Ruggero Campagnoli e Domenico D’Oria, insieme a un ingegnere-enigmista Raffaele “Lello” Aragona, fondano uno strano gruppo, l’Oplepo, acronimo di Opificio di Letteratura Potenziale. Alla cerimonia di fondazione partecipano anche alcuni scrittori francesi, fra cui Marcel Bénabou, segretario provvisorio definitivo di un omonimo gruppo francese, l’Ouvroir de Littérature Potentielle (Oulipo), fondato a sua volta a Parigi nel 1960 da François Le Lionnais e Raymond Queneau, di cui sono membri attivi, fra gli altri, scrittori del calibro di Georges Perec e Italo Calvino (sarà proprio Calvino a tradurre l’acronimo francese in Opificio di Letteratura Potenziale). A dirla tutta, l’origine dell’Oulipo francese, e di riflesso dell’Oplepo, è in una delle tante Sottocommissioni di Lavoro del Collegio di ‘Patafisica, accademia dello sberleffo e della fumisteria, dove per Patafisica s’intende la scienza delle soluzioni immaginarie teorizzata da Alfred Jarry. Insomma, il fatto è che i nostri tre oplepiani s’ispirano all’attività del gruppo francese per dar vita all’Oplepo, che ha avuto tra i suoi presidenti Edoardo Sanguineti e ora è presieduto da Elena Addomine. Cos’è questo gruppo italiano, con questo bizzarro nome? Cosa fanno i suoi membri, scrittori, matematici, ricercatori scientifici e manipolatori del linguaggio, che si ritrovano in questo opificio? Detto in estrema sintesi, giocano con le parole, fanno degli esercizi, creando testi sulla base di una regola ben precisa, di una costrizione, ad esempio scrivere un testo senza usare una lettera (lipogramma). Al riguardo, Perec ha scritto un intero romanzo, La disparition, senza usare mai la lettera “e”, romanzo che è stato tradotto in italiano, sempre senza usare la “e”, da Piero Falchetta che, guarda caso, è un membro dell’Oplepo. 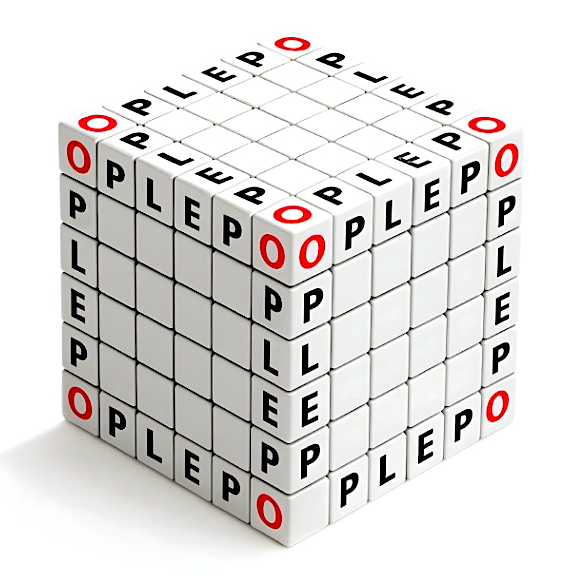 Il carattere “potenziale” della letteratura praticata dall’Oulipo-Oplepo è tale perché si tratta di una letteratura che ancora deve prendere forma, sbocciare, da farsi, da scoprire in opere preesistenti o da inventare di sana pianta attraverso l’uso di nuove procedure linguistiche, una letteratura mossa dall’idea che la fantasia, l’immaginazione ri-creativa non piovono dal cielo o da una fantomatica ispirazione, ma trovano uno stimolo nel rispetto di regole, di vincoli, di costrizioni (contraintes dicono i francesi), esplicite o nascoste. La costrizione è strumento creativo, che amplifica le possibilità di raggiungere soluzioni originali, bizzarre: l’essere «costretti» a seguire certe regole induce uno sforzo di fantasia; la costrizione non restringe l’orizzonte delle strategie narrative dello scrittore, al contrario ne allarga le «potenzialità visionarie», paradossalmente è «un inno alla libertà d’invenzione», capace, come «il meccanismo più artificiale», «di risvegliare in noi i demoni poetici più inaspettati e più segreti» (Calvino). Dalla fondazione dell’Oplepo sull’isola di Capri sono passati esattamente 35 anni e per festeggiare degnamente la ricorrenza alla Biblioteca cantonale di Bellinzona, diretta da Stefano Vassere, promotore instancabile di eventi culturali di grande interesse, hanno pensato bene di allestire una mostra curata da Paola Piffaretti, architetto, collaboratrice scientifica della Biblioteca stessa, e Joshua Babic, ricercatore presso l’Università della Svizzera italiana nonché membro dell’Oplepo. La mostra s’intitola Oplepo in biblioteca, anche. 35 anni dell’Opificio di letteratura potenziale, titolo duchampiano che ricorda quello di una delle opere più significative di Marcel Duchamp, artista dadaista, La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche, senza dimenticare che Duchamp è uno dei numi tutelari (un «plagiario per anticipazione») dell’Oulipo. Accompagna la mostra un libretto della collana TicinoLettura. La mostra si inaugura giovedì 2 ottobre alle ore 18:30 presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona (viale Stefano Franscini n. 30a) e resterà aperta fino al 13 novembre di quest’anno. Sono previsti atelier e conferenze, sempre in biblioteca. In mostra il visitatore troverà un ampio ventaglio di materiale dell’attività dell’Oplepo, le plaquette e i quaderni del gruppo, fra quest’ultimi I neologissimi di Luigi Malerba, divertente campionario di parole inventate. Una serie di pannelli riproducono alcuni funambolici esercizi oplepiani. Ad esempio, Le traduzioni omografiche di Elena Addomine dove un testo in italiano: «Lo vedi, / paga in amore, / tremo rapita […]», diversamente scomposto diventa un testo inglese di senso: «Love dip, / again a more tremor: / a pit, a… […]»; Le ripartite di Aldo Spinelli dove la vocale “e” rimbalza nel testo («Eh già. Potrei iniziare così, in questo modo […]») esattamente e solo dopo otto lettere; o ancora Il Divino intreccio di Stefano Tonietto, una riscrittura senza l’uso della “a” del primo canto dell’Inferno dantesco: «Nel mezzo giusto dell’esister nostro / Mi colsi perso dentr’un bosco oscuro / ché il dritto sentier più non fu mostro», nel rigoroso rispetto della struttura metrica del Divino Poeta; o una versione monosillabica dell’Infinito di Leopardi fatta da Luca Chiti: «Mi fu nel cuor / ad or ad or / quel mio bel col / che sta da sol». Saranno esposti libri, anche d’artista, lettere (una di Calvino a Giambattista Vicari, fondatore della mitica rivista «il Caffè»), opere visive, documenti delle iniziative pubbliche dell’Oplepo. Al vernissage è gradito l’abito in regola. Oplepo in biblioteca, anche 35 anni dell'Opificio di letteratura potenziale Bellinzona (Svizzera) Biblioteca cantonale Fino al 13 novembre
«Domenica - Il Sole 24 Ore», N. 267, 28 settembre 2025, p. XV. Per la versione in pdf di questa recensione cliccate qui.  Per andare o ritornare al menu delle mie collaborazioni alla «Domenica de Il Sole 24 Ore» cliccate qui. HOME PAGE TèCHNE RACCONTI POESIA VISIVA |