|
LA «CONTRAINTE» E I PAZZI LETTERARI Nell’ambito
dell’esperienza oulipiana la
«contrainte»
è considerata (vissuta come) uno strumento
creativo, una
«source
de liberté» che amplifica le
possibilità di
arrivare
a soluzioni originali, bizzarre, inattese,
imprevedibili: l’essere
«costretti»
a seguire certe regole induce uno sforzo di fantasia,
stimola
l’invenzione
di percorsi labirintici, di circumnavigazioni
acrobatiche del
linguaggio.
La «contrainte» non restringe l’orizzonte
delle strategie
narrative
dello scrittore, al contrario ne allarga le
«potenzialità
visionarie», come ha scritto Italo Calvino,
risvegliando
«in
noi i demoni poetici più inaspettati e più
segreti».

ÉLOGE DE LA CAISSE NATIONALE
DES
RETRAITES Oh! combien cette Caisse en sa
présence
au monde, O P A R I S!O
F R A N
C E!
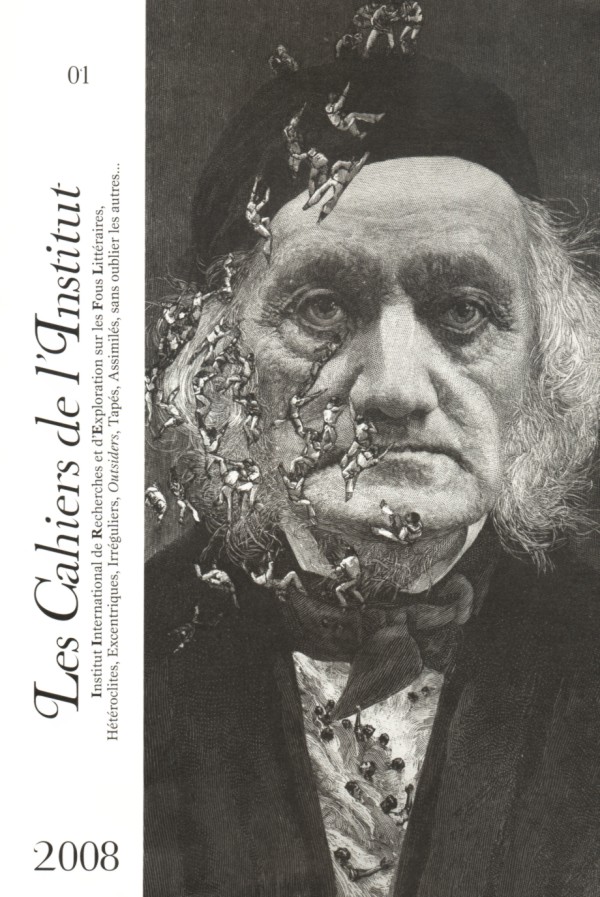
Cetti riassume la sua teoria con questa «regola
delle
regole»:
«è solo coll'usar, pur col debito riguardo
a chiarezza, il
minor numero possibile di sillabe, che si può
conseguir la
perfezion
dello stile». La lingua italiana, che ha il pregio
di essere
armoniosa
e di scriversi come si pronuncia, ha in più il
dono della
brevità.
I dialetti, ad esempio il lombardo, sia nella grafia che
nella
pronuncia,
sono più brevi dell'italiano e quindi sono uno
strumento
più
perfetto d'espressione delle idee e dei sentimenti,
anche se hanno il
limite
di essere compresi da poche persone. Il loro uso non
può che
favorire
lo sviluppo dell'intelligenza e del carattere. Per bocca
dei suoi
personaggi,
Cetti avanza la proposta di fondare una
«Società per il
progresso
e perfezionamento della lingua» con il compito di
bandire
concorsi
a premio consistenti nel: a) presentare saggi
d'emendazione di brani di
prosa di nostri illustri scrittori; b) fornire elenchi
di vocaboli che
si possono scrivere in due differenti modi, al fine di
eleggere
stabilmente
il più breve; c) proporre la semplificazione
sillabica di parole
lunghe. Come il secolo scorso ha visto trionfare il
«purismo»,
Cetti si augura che questa possa essere l'epoca del
«Brevismo».
A suo parere nuocciono alla brevità l'abuso della
congiunzione
«e»,
l'uso del «d eufonico» che si aggiunge alla
congiunzione
«e»,
dell'«i» messo in principio alle parole che
iniziano per
«s
impura», delle preposizioni articolate (meglio
dire «le
città
di Francia» che «le città della
Francia»),
degli
inutili partitivi («c'erano oggetti» e non
«c'erano
degli
oggetti»), l'eccesso di «che»,
«di»,
«come
se», degli avverbi in «mente», dei
superlativi, ecc.
Anche i segni d'interpunzione permettono di risparmiare
parole, a
vantaggio
della rapidità e dello stile; invece che «i
due amici
discorrevan,
mentre le note d'una canzone salivan dalla via»
meglio dire
«i
due amici discorrevan: le note d'una canzone salivan
dalla via».
Altre regole per valorizzare la brevità
individuate dal Cetti
sono:
1. omettere tutto ciò che l'uditore o il lettore
possono
facilmente
sottintendere; 2. disporre le parole in modo accorto
nelle frasi e nei
periodi; «vidi un monte verdeggiante di pascoli,
boscoso,
altissimo»
non va, devo dire «vidi un monte altissimo,
boscoso, verdeggiante
di pascoli»; 3. scrivere usando periodi in
prevalenza brevi,
ciascuno
dei quali esprima un concetto a sé, ben distinto
dagli altri,
andando
spesso a capo. Io ho lungamente ricusato di creder vere le cose che dirò qui sotto, perchè, oltre che la mia natura era troppo rimota da esse, e l'animo tende sempre a giudicare gli altri da se medesimo, la mia inclinazione non è stata mai d'odiare gli uomini, ma di amarli. In ultimo l'esperienza quasi violentemente me le ha persuase: e son certo che quei lettori che si troveranno aver praticato cogli uomini molto e in diversi modi, confesseranno che quello ch'io sono per dire è vero; tutti gli altri lo terranno per esagerato, finchè l'esperienza, se mai avranno occasione di veramente fare esperienza della società umana non lo ponga loro dinanzi agli occhi. che applicando il metodo cettiano diventa: Ho
ricusato a lungo, di creder vere le cose
che qui dirò,
perchè, oltre che l'indole mia era assai remota
da esse, - e
l'animo
tende a giudicar gli altri da sè - non fu mai
mia inclinazione
odiar
gli uomini, ma amarli. Ma il vero
«capolavoro» del Cetti è il Rifacimento
dei
Promessi Sposi (Como, a cura dell’Autore, Soc.
Arti Grafiche S.
Abbondio, 1965) dove il brevismo conosce la sua
realizzazione
più
originale e profonda. Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a restringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. diventa nella versione cettiana: Quel ramo del Lario che, tra due catene di monti e tutto seni e golfi, volge a sud, quasi a un tratto si restringe e, tra un’ampia costiera a manca e un promontorio a destra, prende corso di fiume; mutazione resa più evidente da un ponte che unisce le due rive lì ove termina il lago e l’Adda ricomincia, per riprendere poi nome di lago, ove esse riaprendosi, lasciano spaziare le acque in nuovi golfi e seni. Nella sua autobiografia
Cetti scrive: «la mia mente, a
differenza
di quel che avviene per la maggior parte degli uomini,
non accoglie le
idee da altri, ma le produce» (Carlo Cetti, Autobiografia,
Como, a cura dell’autore, Soc. Arti Grafiche S.
Abbondio, 1961, p. 48). We were not more than twelve days from the Line, when a high wind took us off we knew not where. All at once there was a cry of «Land!» and the ship struck on a bank of sand, in which she sank so deep that we could not get her off. At last we found that we must make up our minds to leave her, and get to shore as well as we could. There had been a boat at her stern, but we found it had been torn off by the force of the waves. One small boat was still left on the ship’s side, so we got in it. Misteriosamente nel suo
rifacimento la scrittrice inglese si
prende
alcune libertà, come far morire Venerdì
prima della fine
del romanzo. La Godolphin è autrice di altri due
libri
monosillabici Sandford
and Merton, in words of one syllabe (1868?) e The
pilgrim's
progress,
in words of one syllabe (1884), entrambi
pubblicati a New York. Intervento al convegno su «Écritures et lectures à contraintes» organizzato dalla rivista «Formules», revue des littératures à contraintes diretta da Jan Baetens e Bernardo Schiavetta, convegno svoltosi al Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle dal 14 al 21 agosto 2001. Questo testo è uscito nella traduzione francese di Tanka G. Tremblay sul numero 1, 2008, pp. 73-80, di Les Cahiers de l'Institut, rivista dell'Institut International de Recherches et d'Exploration sur les Fous Littéraires costituitosi a Fontenoy-la-Joute in Francia nel 2007. Per leggere la traduzione di Tremblay cliccate qui. Per andare al menu delle mie collaborazioni a Les Cahiers de l'Institut cliccate qui. Questo testo è citato nel saggio di Silvia Rogai, La "serrana" e il labirinto di "contraintes", apparso sulla rivista «Tradurre», n. 5, autunno 2013.    HOME PAGE TèCHNE RACCONTI POESIA VISIVA |